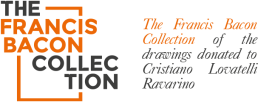La mia collezione d’arte è una storia di famiglia

Villiam Zaghi – Bosco a Vidiciatico – Olio su tavola- 1964
Non è un caso che nella mia collezione ci sia un dipinto totalmente fuori contesto.
E che invece ne è la genesi.
Lo ha fatto mio zio Villiam, con la vu semplice e non con la vu doppia a testimoniare l’autarchia linguistica del fascismo durante il quale, nel 1927, era nato.
Lo stesso anno in cui era nata mia madre.
In un pomeriggio brumoso del mese di febbraio del 1964 eravamo andati assieme in giro per i boschi nei dintorni di Vidiciatico, io ad accompagnarlo e lui a disegnare gli alberi d’inverno per cogliere la luce dorata che quel giorno slargava i contorni del tronco e dei rami con toni nebbiosi, quelli che si vedono oggi “guardando” il dipinto e che il tempo e la nostalgia hanno reso ancora più morbidi.
Lo zio Villiam nella mia vita c’è sempre stato.
Laureando in architettura, pittore, fotografo e, soprattutto, mio professore di disegno e storia dell’arte al liceo scientifico Augusto Righi, sezione distaccata di Porretta Terme.
Per cinque anni – tra il 1962 e il 1966- ogni lunedì mattina sono andato a scuola con lui, da Vidiciatico a Porretta e ritorno, sulla sua Fiat 600 bianca, ascoltando all’andata, tra il sonno e la veglia, l’anticipo della sua lezione e, al ritorno, riascoltandola sotto forma di commento, sempre e solo suo.
Perché mio zio, la persona più mite che io abbia mai conosciuto, chiudeva gli spazi.
Nel fluire continuo delle sue parole non c’erano pause, sospensioni o semplicemente vuoti di respirazione che consentissero un inserimento.
La stessa cosa faceva sua moglie, mia zia Linda, abbreviativo di Olinda, sorella di mia madre.
Quando stavo con loro – e capitava spesso perchè per molti anni, prima di trasferirsi a Villa Mara, hanno abitato al primo piano della vecchia casa della famiglia di mia nonna della quale noi occupavamo il secondo piano – assumevo il compito di “direttore del tempo” assegnando a ciascuno di loro quello che gli serviva in modo che ce ne fosse anche per l’altro.
Facevano buon viso ad un gioco che non amavano .
Alla vigilia di Natale dei mie sedici anni lo zio Villiam, la sua Fiat Seicento bianca ed io partimmo da Vidiciatico alla volta di Napoli: andavamo a passare le feste da sua madre e suo padre.
Il Prof. Carlo Zaghi, suo padre, al contrario della Signora Pia, sua madre, era un uomo divertentissimo, pronto alla battuta e allo scherzo. Mi chiamava Bibi, soprannome che ancora mi porto addosso e si presentava come un nonno burlone, ma era una persona di eccezionale carattere e di vastissima cultura.
Tenace antifascista, perseguitato dal regime ma tollerato in quanto storico di prim’ordine, durante la Seconda guerra mondiale era riuscito a scappare al servizio militare ma, all’indomani dell’armistizio dell’8 settembre, si era unito alle bande dei partigiani nei dintorni di Ferrara venendo poi catturato e condannato a morte. Dopo 114 giorni di prigionia e un fallito tentativo di fuga, solo l’azione coraggiosa della moglie e una fortunata serie di circostanze lo avevano salvato dalla deportazione e dalla fucilazione che invece era toccata ai suoi sette compagni di lotta, i cui nomi si leggono ancora oggi su una lapide che si trova nel muro di cinta del fossato del Castello di Ferrara, nel luogo dove anche lui avrebbe dovuto essere fucilato.
Professore di Storia moderna e di Storia dell’Africa alla Federico II di Napoli, abitava all’ultimo piano del palazzo dei giornalisti di Via Petrarca.
Per alcuni anni era stato direttore de Il Giornale quotidiano napoletano fondato nel 1944 da Benedetto Croce con il quale era in strettissimi rapporti al punto che era stato proprio Croce a volergliene affidare la direzione nel 1947.
Era poi diventato famoso non solo per le sue qualità di storico e giornalista ma soprattutto per una vicenda anacronistica che la dice lunga sul suo carattere.
“Il Giornale di Zaghi si manteneva su correnti di sinistra liberale ma molti lo giudicavano di tendenza fascista. Per difendere l’onorabilità della testata da quell’accusa infamante, Zaghi finì per sfidare in duello il direttore del La Voce ferendolo gravemente.”
Dalla terrazza della sua casa con una mano si poteva toccare il Vesuvio e con l’altra Capri mentre con lo sguardo si attraversava l’intero golfo.
Mi ritrovai così in un mondo di cui non avevo neppure immaginato l’esistenza e che era distante le mille miglia da quello nel quale io vivevo a Vidiciatico.
Un mondo che osservandolo da vicino mi apparve ancora più distante da quello che avevo visto attraversando il centro di Napoli la sera del nostro arrivo e che mi fece riflettere per la prima volta sulla vera distanza tra le persone che non è quella geografica ma quella delle condizioni sociali e culturali delle quali fino a quel momento non mi ero accorto perché sulle montagne dell’Appennino le classi sociali non avevano quella evidenza, appiattite da una condizione di vita che era marginale per tutti.
Vidiciatico aveva da poco iniziato ad uscire dalla povertà del dopoguerra e non solo non esistevano case così eleganti ma, prima ancora, non esisteva il tipo antropologico delle persone che vi abitavano e, cosa che ancora di più colpi l’ingenuità dei miei sedici anni, non ne esisteva uno che potesse assomigliare all’umanità che vedevo sui marciapiedi delle vie del centro.
Dovunque c’erano fuochi con attorno persone che si scaldavano e si vedeva che molti di loro cercavano di vendere e comprare qualcosa, dalla frutta alle sigarette e chissa’ cos’altro.
Era una Napoli che mi appare oggi come la fotografia di quella dei romanzi di Elena Ferrante, chiunque essa sia, ma che allora mi si presentò davanti come l’immagine vivente di un presepe nel quale la miseria della vita vissuta assumeva i caratteri della commedia dell’arte, sterilizzandola.
Grazie a quella terrazza così alta e lontana dalle vie del centro, la Napoli nella quale era vissuto mio zio e nella quale viveva la sua famiglia, quella che io conobbi e che per un paio di settimane frequentai mi sembro’ enormemente distante da quella vera: mi apparve addirittura come un mondo che non avesse niente a che fare con la normalità e che al di là dei discorsi “ontologicamente” intelligenti che tutti facevano seduti nei loro salotti eleganti saltabeccando tra marxismo, idealismo ed esistenzialismo la vera radice di quel mondo alla fine dei conti fosse una sola: il privilegio.
Il sessantotto mi fece poi capire quanto avesse ragione Carlo Marx a dire che l’essere sociale determina la coscienza.
Ma questa è tutta un’altra storia.
Può darsi che la mia memoria sia imprecisa ma ricordo che una sera andammo a cena da amici di mio zio che abitavano in uno dei piani di mezzo del Palazzo di Via Petrarca e lì conobbi una sua amica che faceva la giornalista e che si chiamava Anna Parlato e che poi seppi essere quell’Anna Grimaldi uccisa proprio in Via Petrarca nel marzo del 1981.
Nella camera dove dormivo e dalla cui porta finestra si entrava direttamente sul lungo terrazzo ricoperto di piastrelle di maiolica colore azzurro dal quale ogni mattina guardavo uno dei più bei panorami del mondo, c’era un quadro dipinto alcuni anni prima da mio zio.
Era un quadro giallo, con tonalità che variavano dallo scuro al chiaro spatolate attorno ad un cancello fatto di luce: una serie di sfumature gialle percorse da trasparenze verticali che nella loro sommità si mescolavano ad un cielo che era anche azzurro.
Mi pare che mio zio lo avesse chiamato “Cancello di Capodimonte” ma per me è sempre stato “O sole mio”.
Insomma mio zio era un pittore. Ma era anche uno scultore, ed era bravo!
Ancora oggi nel muro che costeggia la breve scalinata che precede la porta d’ingresso della sua casa di Formia si può vedere un bassorilievo che ritrae un gruppo di pescatori che tira a riva una rete con i muscoli tesi delle cosce e delle braccia e con i tendini tirati dei loro colli taurini.
Forse anche per questo il mio ricordo più risalente di un toro che sta per cadere: ricordo il pezzo d’argilla appoggiato su un piedistallo dal quale mio zio aveva preso le mosse e il suo lento trasformarsi in una figura che prendeva la forma di un animale poderoso e morente che aveva però bisogno di essere costantemente inumidito e che per questo era spesso coperto con uno straccio bianco bagnato.
Quella volta mio zio mi insegnò la tecnica che utilizzava per trasformare in bronzo il suo toro d’argilla e che si chiama, così mi pare, della “cera persa”.
Cosa c’entra tutto questo con la mia collezione d’arte?
Mio zio Villiam ne è la fonte.
Sfogliavo i suoi libri d’arte, quei pezzi unici che le grandi banche regalavano di tanto in tanto alle persone importanti e che lui riceveva tramite suo padre. Ascoltavo i suoi racconti sui pittori e sulla storia dell’arte, architettura compresa. Iniziai a farmi regalare e a comprare io stesso libri d’arte e, appena ne ebbi la possibilità, a comprare opere di pittura. Il mio interesse per l’arte mi ha spinto verso i giovani artisti che a partire dalla fine degli anni sessanta vivevano a Bologna e che incontravo nella zona universitaria che dal 1968 in poi era diventata la nostra seconda casa.
La mia collezione è cresciuta così a poco a poco grazie a quegli incontri e, alla fine, sempre per vie casuali, è arrivata a Francis Bacon.
Una collezione che per questo non è fatta solo di dipinti ma di storie che prima o poi racconterò, guardando una per una le opere che ne fanno parte e lasciando correre liberi i ricordi percorrendo a ritroso tante parti della mia vita.
Come ho fatto con il quadro di mio zio Villiam.
“Genesi”.
Umberto Guerini